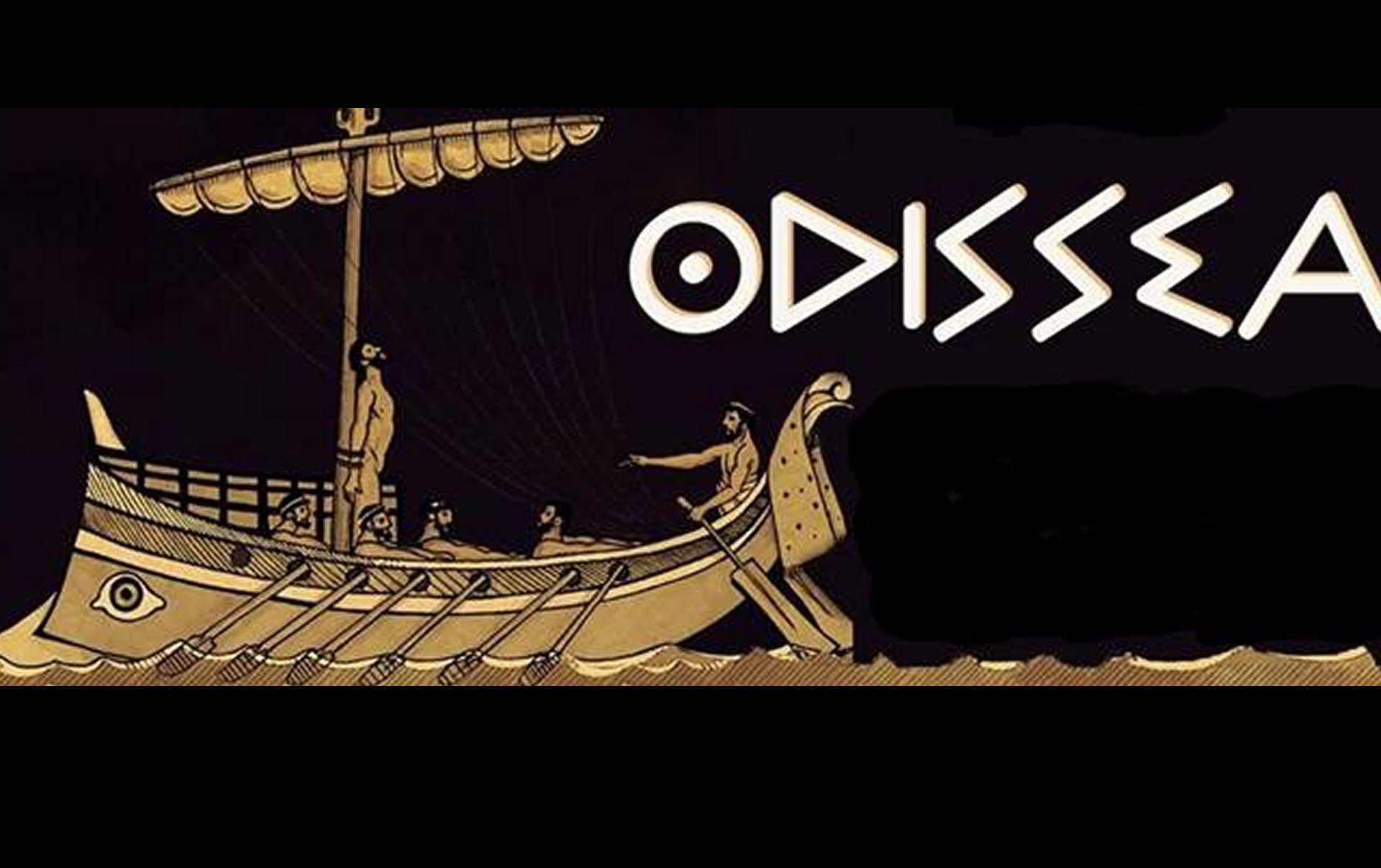La necessità di chiudere sollecitamente, avendo portato la conversazione oltre i limiti di tempo prefissati, mi ha indotto a tralasciare ogni accenno ad una considerazione cui avrei voluto fare riferimento. Me se ne offre qui il destro e colgo volentieri l’opportunità di porvi rimedio.
L’Odissea – è stato detto – è opera totalmente allegorica e da interpretare, esigenza che, quando l’obiettivo voglia essere l’ottenimento di un quadro generale complessivo della natura dell’opera, dei sentimenti del poeta, delle ragioni storiche che l’hanno ispirato, dell’ambiente umano in cui le vicende narrate si sviluppano, merita una qualche riflessione.
Lewis Greeville Pocock giustamente osserva come il poema s’impernia sui fatti. Se così stanno le cose, è lecito sostenere, ad esempio, come l’irriguardosità di Polifemo nei confronti di Giove, invocato da Ulisse, ed il suo rivolgere, per converso, preghiere rispettose a Poseidone non debbano essere frutto di mera invenzione poetica ma trovare, per il modo di essere e di agire del Ciclope, un concreto rapporto causale che sia oggettivamente apprezzabile.
A mio modo di vedere, ciò assume la precisa funzione di evidenziare una concezione di vita ed esperienze contrapposte e rivali. Storicamente, con i Fenici che da Sidone a Gibilterra dominano il mare, chiunque avesse voluto vivere in quell’area avrebbe dovuto fare i conti. Cosicchè i viaggi di Ulisse divengono, in realtà, le peregrinazioni di un inviato dai Fenici in esilio, perchè l’eroe di essi teme lo straripante potere e contro di essi, malgrado l’intrinseca debolezza del confronto, egli cerca di affermare la propria personalità. Nelle avventure di Ulisse vi è costrizione ma il loro racconto, al tempo stesso, è indice di non domata rivendicazione.
Per logica ed evidenza consegue – nel quadro delle indagini e delle sensazionali scoperte di Samuel Butler, di Lewis Greeville PocockL.G. Pocock (1890-1975) , è stato un Professore di lettere ... Leggi e di Vincenzo Barrabini – che l’ira di Poseidone stia a rappresentare, sotto la trasfigurazione poetica e nel suggestivo mascheramento dei fatti, l’ira dei Fenici così come l’aiuto di Minerva voglia simboleggiare, in contrappunto, la mentalità ed il mondo greco. Nettuno è lo straniero venuto dal mare che riporta i Feaci sul mare, acconcia alle loro qualità marinare, pur non abbandonando Ypereia, la città dei Sicani. Vicinanza e comunanza fra i due popoli, a dispetto di comuni parentele, mettono Ulisse inevitabilmente in lotta anche con Polifemo, dato che le antiche e primitive abitudini terragne e la vita pastorale dei Ciclopi, alla lunga, caratterizzano un’epoca in via di progressivo esaurimento e non possono coesistere con un’inarrestabile evoluzione in atto.
Dietro questa apparente ed episodica cronaca che, in sintesi, Lewis Grenvile Pocock definisce essere un racconto di fazioni tra le comunità elime e delle relazioni esistenti tra questi e i dominatori, i Fenici stanno, in netta antitesi ed in chiara opposizione, tre mondi diversi: quello fenicio è la vecchia civiltà che viene dall’oriente; Ulisse e la sua gente sono l’inizio di una nuova civiltà. Essa vuole sovrapporsi al passato, senza più ragione, cui impone, con idee nuove ed originali, un diverso indirizzo.
Poeta e personaggio sono dunque l’immagine ed i protagonisti di un processo storico grandioso: è l’affrancazione dell’Occidente – quale si avvertirà nelle lotte fra Greci e Persiani esaltate da Erodoto ed Eschilo – dalla cultura dell’Oriente, la nascita di un sentimento, di un’autocoscienza e di una consapevolezza propri ed originali che finiranno con l’opporre razionalità a fatalismo, ragione a magia, iniziativa ad istinto, dinamismo a contemplazione.
Dopo di allora, all’Occidente capiterà ancora di orientalizzarsi, ma ciò avverrà solo nei periodi di crisi o allorquando perde il senso, dimentica il significato, trascura il ricordo dei valori che hanno caratterizzato ed alimentato la sua civiltà. Universale è, invece, l’eterna lotta fra vecchio e nuovo e l’attestazione del fatto che il tempo non si può fermare nè è possibile andare all’indietro. Nell’ambientazione siciliana dell’Odissea – antitradizionale ma indiscutibile, dissacrante ma realistica, delineata per intuizioni ma suffragata da ripetuti mezzi di prova – il poeta e l’eroe interpretano il mondo nuovo e divengono il simbolo dell’intraprendenza del mondo occidentale, che tende alla ricerca della propria identità ed alla scoperta della conoscenza in generale.
E’, quindi, una rivelazione essenziale che il poeta sia occidentale.
Ai giorni nostri, l’attualità dell’Odissea, si manifesta proprio per questi due aspetti: occidentalità della civiltà e perseguimento del progresso e c’è oggi il pericolo concreto che entrambi vadano perduti.
Non sono, forse, sintomi di una perniciosa forma di involuzione la passività dello sportivo allo stadio o dello spettatore incantato da una sciocca rappresentazione televisiva? Si è osservato che la TV faccia compagnia a chi è solo ma riesca ad isolare persino chi si trovi in compagnia, così come, in uno stadio di centomila persone, siano pochissimi a fare e tutti gli altri restino, desolatamente inerti, a contemplare. Anche per Roma, nel periodo di decadenza, panem et circenses hanno rappresentato l’aspirazione massima e contribuito alla disgregazione dell’impero.
Il progresso della scienza è irrinunciabile, con buona pace di chi auspica (primo timore) il ritorno ad un mitizzato ma irreale buon tempo antico. Condizione necessaria è, però, che non si abbandonino i valori ed il senso della vita o se ne assumano i benefici effetti, scambiando i mezzi con il fine (secondo timore), quali valori veri della vita.
Può sembrare paradossale ma non mi pare, però, altrettanto essenziale, per Ulisse, essere specificamente siciliano perchè, rispetto alla sua nazionalità, si rivelano di maggior spessore i valori che attraverso di lui si propongono, anche se, sin da allora, essere siciliano poteva magari significare il raggiungimento di un livello avanzato di civiltà. Per quanto Ulisse sia falso, uccida e faccia uccidere, nel bene e nel male, egli è sopratutto e profondamente umano ed è proprio, la sua umanità (esattamente all’opposto di Achille il quale, perfetto ma asettico, lascia completamente indifferenti), che attira su di lui un naturale senso di simpatia e di comprensione.
Il saperlo siciliano non sposta nè intacca minimamente il giudizio sul personaggio. Sicilianità – ha sostenuto molto opportunamente e con il valore della sua esperienza il socio Santi Correnti in uno scritto apparso di recente sul Notiziario – significa valutazione realistica e documentata di quello che la Sicilia è, nel bene e nel male. Ma valutazione realistica significa, a sua volta, comprensione, approccio che si può nutrire con affetto di siciliano o con razionalità di alieno. Come razzista è chi che si rifiuta di capire, antirazzista è chi si pone nella condizione di capire, magari, poi, dissentendo. Non inevitabilmente chi condivide.
Capire l’uomo è capire, dunque, anche l’uomo siciliano. Per riscontrare l’identità dell’uomo nelle differenze fra gli uomini ed individuare orizzonti di umanità comune al di sopra delle distinzioni tra etnie, religioni, tradizioni. Perchè l’uomo, pur vivendo il proprio tempo, sia inserito in un’epoca plurimillenaria. Per non perdere – è imperativo rimediare al più presto alla dissoluzione di valori in atto – e non disperdere quei valori umani che hanno determinato la nostra civiltà e non si traducono nel ritorno alla povertà, alle scomodità e ai disagi del passato, ma unicamente in una ritrovata messa a frutto, in linea con l’evoluzione dei tempi, del dinamismo e dell’intelligenza umana, delle ragioni dell’esistenza dell’uomo che è, in Triskelès, la miglior causa del motto conosci te stesso.
© Carlo Callioni 2011