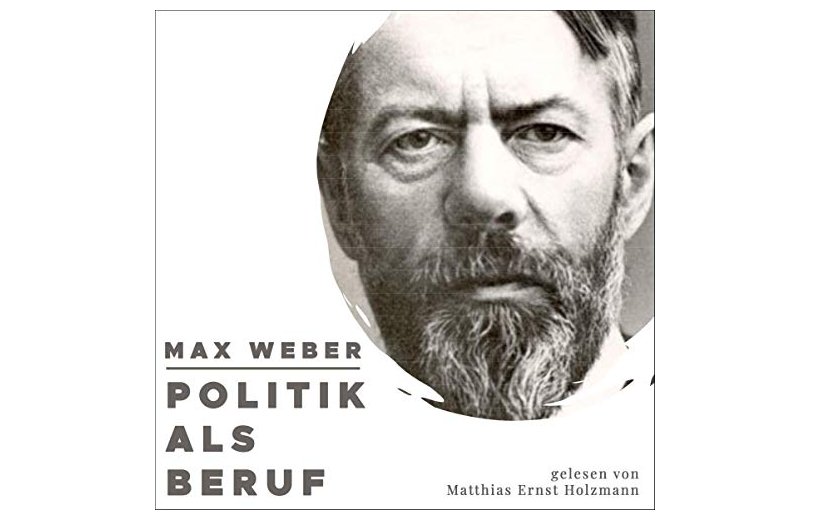Ricordando come, in dottrina, sia diffusa l’idea che il dovere rappresenti la situazione giuridica soggettiva di base del diritto, ancor prima, quindi, di entrare nel merito dell’argomento se si giudica la definizione corretta, si può almeno immaginare vi debba essere una qualche ben definita proporzione fra diritti e doveri e, con Antonio Rosmini, si può affermare che la persona umana abbia valore morale di modo che da questo valore discenda il dovere primario del rispetto degli altri in quanto persone.
La realtà attuale, preponendo quel sapere egoistico che deriverebbe i doveri dai diritti anziché i diritti dai doveri, sottolinea un totale rovesciamento di fronte. Si tacciono o si obliterano i doveri. Spesso, addirittura, i problemi sono valutati più in termini di diritti che di giustizia. Non é una prova e neanche un indizio ma é sintomatico constatare come persino la Costituzione italiana, nei suoi 139 articoli (più le 18 disposizioni transitorie e finali, in totale 157 articoli) ripeta ben 60 volte la parola diritto (o diritti), una volta ogni due articoli e mezzo, ma solo 8 volte, una volta ogni venti articoli, dovere (o doveri). È altresì curioso notare come in essa si parli di dovere solo nella prima parte (gli articoli da 1 a 54 che riguardano i cittadini) e mai nei molti più articoli della seconda, a proposito di parlamento, presidente della Repubblica, governo, magistratura, regioni, province e comuni (art. 55 – art. 139, ordinamento della Repubblica).
C’è inflazione di diritti. Del bambino, dell’anziano, del malato (e di ogni diversa specie di malato), del morente, dell’handicappato, delle donne, dei neri, di qualsiasi gruppo che possa sembrare formi una minoranza o anche di categorie più ampie purché possa sembrare siano oggetto di una qualche discriminazione. Siamo sommersi dalla moda ideologica dei diritti dell’uomo che moltiplica desideri e diffonde bisogni, aspettative e richieste che, in veste di diritti anche quando non lo sono, vengono sollevati ad ogni piè sospinto. Non si compra più nemmeno un golfino se non ci si trova appiccicata sopra un’etichetta a garanzia del rispetto, fabbricandolo, dei diritti dell’uomo. Ci si potrebbe fermare qui lasciando a ciascuno di valutare la questione secondo la propria sensibilità se non fosse il caso di aggiungere alcuni altri elementi e di prospettare qualche ulteriore riflessione, giusto per dare un assetto almeno razionale al discorso.
Parlare di diritti, significa parlare di diritto e dell’uomo, dell’uomo come soggetto di diritto e del diritto come strumento per regolare i rapporti fra gli uomini. Badando che l’ordine e l’ottica per riguardare l’argomento debbano sempre essere: prima, assolutamente prima, l’uomo e solo dopo il diritto, dato che nel caso inverso il diritto si imporrebbe all’uomo facendogli perdere la libertà. È vero che lo stato ha il monopolio del diritto come diceva Max WeberKarl Emil Maximilian Weber (Erfurt, 21 aprile 1864 – Monac... Leggi ma oggi lo stato in quanto sovrano deve tener conto di diritti che non discendono da Dio o dall’autorità regale ma sono un esempio di soft law che parte dal basso. La vita umana si fonda su un anelito di libertà anche se l’uomo, animale socievole, avverte che la libertà senza limiti (si dice: la mia libertà termina dove comincia la tua oppure, utilizzando un principio più sofisticato, ubi societas ibi jus) sfocia nel sopruso e il sopruso facilmente nell’abuso e nel bellum omnium contra omnes di Thomas Hobbes. L’uomo abbisogna di reazioni prevedibili, di regole per mantenere l’ordine, essendo l’imprevisto il portato del disordine. Da qui l’ordinamento giuridico che assicura legalità. Il diritto racchiude in sé, purtroppo, solo una promessa di giustizia. Hans Kelsen parlava di giustizia come ideale irrazionale. Il diritto infatti non é in grado di garantire la legittimità che, sempre, é stata indotta dal consenso e che nei tempi moderni è determinata dal consenso democratico, in assenza del quale subentrano autoritarismo, forza bruta od arbitrio, singolarmente o in coppia o tutti e tre insieme, che fagocitano la libertà. E si deve ricominciare tutto da capo. Nell’aspetto sociologico e politico si prospetta un dilemma simile. Esso ha attraversato la storia del pensiero umano e, come manifestazione di filosofia sociale, si ricollega al contrasto tra realismo e nominalismo. Il fine é l’uomo o lo stato? I filosofi della Grecia antica, Aristotele incluso, non erano individualisti e la Repubblica di Platone aveva cercato di definire una buona comunità, la mitica città ideale, e non un buon individuo. Solo con la perdita delle libertà politiche, da Alessandro Magno in poi, comincia a svilupparsi l’individualismo, inizialmente ad opera dei cinici e degli stoici (sono gli stoici a dichiarare per primi l’esistenza di un diritto naturale anche se Aristotele aveva ribadito lo stesso principio nell’Etica Nicomachea). Tradotto nel principio della centralità dell’uomo, l’individualismo era anche opinione propria del Cristianesimo, almeno prima che questo abbandonasse la spiritualità per iniziare una secolare rivalità con il potere temporale per essere protagonista nel governo del mondo ed intervenire nel controllo dello Stato o prima di rincorrere illusorie rivendicazioni progressiste o guidare l’islamismo verso una benevola convivenza che la Storia non ha mai mostrato. L’antropocentrismo cristiano fu ampiamente appannato da queste tendenze storiche e sociali senza, per fortuna, mai essere interamente soppresso.
I diritti umani, nell’infinita disputa sui fini fra uomo e stato, sembrerebbero orientarsi a privilegiare l’uomo. Ci si potrebbe dunque aspettare un progressivo allontanamento dei centri del potere dallo Stato verso la società (la c.d. delegificazione) pur con mille ostacoli e tante contraddizioni a condizionarne la marcia. Tuttavia, della presenza dello Stato – invadente o importante, a seconda dei diversi punti di vista – occorre comunque tener conto. Ha sempre avuto, ad esempio, un intrinseco fascino sull’uomo ed un largo seguito negli accadimenti terreni il ricondurre tutte le istituzioni allo Stato. Fa sì che lo Stato assuma la posizione che i teologi, rifacendosi ad un’antica spiegazione teologica, assegnano a Dio. Che però non è detto rappresenti una soluzione verso cui l’umanità oggi invero si muove. In filosofia del diritto si fa strada piuttosto il convincimento che la facilità di movimento nel tempo e nello spazio per lo straordinario sviluppo dei mezzi di comunicazione restringa l’importanza del territorio e comprima il potere statale il quale vive in simbiosi con il territorio. Lo Stato, in ogni caso e almeno per il momento, dispone del potere ed é l’istituzione che ha precetti di pieno valore giuridico applicabili erga omnes. Incessantemente predica il bene comune per i suoi cittadini e ciò lo farebbe ritenere incline ad accreditare i diritti umani. Purtroppo così non è e così non è mai stato. Anzi, lo Stato nemmeno riconosce sempre i diritti umani. Ad es. Cina, Corea del Nord e Cuba, il fior fiore dei pochi Paesi comunisti rimasti al mondo, sono lontanissimi dai diritti umani. Ma anche nei Paesi che si dichiarano apertamente sostenitori dei diritti umani (come l’Italia dove però il 90% dei casi di infrazione riguarda la durata irragionevole dei processi se misurata sul passo dei parametri temporali adottati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo) si hanno ripetute violazioni. Ha esercitato una supplenza degli Stati, l’O.N.U. promuovendo la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Non è però tutto oro quel che luccica nemmeno per l’O.N.U.:
· intanto non tutti gli associati hanno adottato la Dichiarazione universale dei diritti umani senza per questo essere sconfessati e perdere la qualità di associato. E’ una posizione curiosa. Sarebbe come se un incallito ubriacone volesse, per forza ma senza rinunciare alla sua inclinazione, far parte della lega antialcoolica. Un evidente controsenso · inoltre l’atteggiamento dell’O.N.U. non è sempre stato inappuntabile: un’enorme ipocrisia ha contraddistinto ad esempio i rapporti fra O.N.U. e Libia e getta una luce sinistra sulla cacciata di Gheddafi. Sarà stata una dittatura, avrà commesso gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, avrà impiegato mercenari, non avrà avuto regole democratiche di governo, avrà protetto terroristi, nel suo palmares ci staranno tutte le nefandezze di questo mondo, della Libia si potrà dire tutto il male possibile. Ma non è mai stata una novità. Semmai, è sempre stato così o, forse, prima era anche peggio. Nel 2011 però la riprovazione ha implicato addirittura una guerra contro il regime libico quando solo 8 anni prima, nel 2003 (cosa da allora è drammaticamente cambiato?) alla Libia toccò la presidenza proprio della Commissione O.N.U. dei diritti dell’uomo. Né le nefandezze né i crimini contro l’umanità sono oltretutto una specificità o un’esclusiva libica. Nella sola area mediorientale vogliamo ricordare episodi come Settembre nero in Giordania (1970: 5.000 morti), Hama cittadina siriana (1982: 10-20.000 morti) o anche solo la Siria di oggi con la sua primavera araba?
Pare che il concetto di diritti dell’uomo venisse affrontato storicamente per la prima volta nel 539 a.C. da Ciro il Grande (il testo é scolpito sul cilindro di Ciro, rinvenuto nel 1879 tra le rovine di Babilonia ed il reperto é ora conservato al British Museum a Londra). Il documento prodotto nella circostanza sarebbe ritenuto la prima carta dei diritti dell’uomo poiché esprime rispetto per l’uomo in quanto tale e promuove una forma, sia pure elementare, di libertà e tolleranza religiosa. Nel III secolo a.C., Asoka il Grande (Impero Maurya, oggi India) perseguì una politica di nonviolenza e di rispetto per la vita animale. In data 1222, nel giorno dell’incoronazione di Sundjata Keita quale sovrano dell’Impero del Mali, si ha la solenne proclamazione della Carta Manden (tramandata poi oralmente), una dichiarazione di diritti umani essenziali quali il diritto alla vita e il diritto alla libertà. Ma é in Occidente che l’orientamento non rimane un’iniziativa isolata ed estemporanea e diviene un percorso coerente che porta all’inserimento sistematico del principio negli ordinamenti giuridici positivi ed al riconoscimento dei diritti umani. La Dichiarazione universale dei diritti umani è pertanto un codice di importanza storica assoluta che in effetti completa un secolare cammino e tende ad un ideale ricongiungimento fra etica e politica, a favore dell’uomo. È il punto di arrivo di un prolungato dibattito filosofico sull’etica giuridica che ha antenati illustri: il Bill of Rights del parlamento britannico del 1689, la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America del 4 luglio 1776, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino approvata nell’agosto 1789 dai rappresentanti dell’Assemblea Nazionale Francese, all’inizio della Rivoluzione francese, i Quattordici punti del Presidente americano Woodrow Wilson (1918) e i quattro pilastri delle libertà della Carta atlantica di Franklin D. Roosevelt e Winston ChurchillWinston Churchill, primo ministro britannico che ha guidato ... Leggi del 1941.
Si afferma già nell’antichità il concetto di somiglianza fra dèi ed uomini e, con Socrate e con i sofisti, l’attenzione si incentra sull’uomo e sulla sua rilevanza nel mondo. Conosci te stesso, diceva Socrate. Per Protagora l’uomo è la misura di tutte le cose. Ancora prima, chi più e chi meglio di Epicuro poteva sostenere la centralità dell’uomo nel mondo? Tuttavia occorre distinguere. Non si trattava di una convergenza dal basso verso l’alto ma dall’alto verso il basso perché erano gli dèi ad assomigliare agli uomini, anche nei loro difetti. La ricchezza dell’Occidente è il prodotto di secoli di cultura cristiana ed il progresso scientifico e tecnico e lo sviluppo politico e sociale non si spiegano senza il profetismo ebraico e l’antropocentrismo cristiano. L’humanitas del mondo cristiano implica più di ogni altra cosa la centralità dell’uomo che eleva, dal basso verso l’alto, l’uomo a immagine di Dio. Ciò permea il clima intellettuale, le costumanze e la civilizzazione dei popoli occidentali. É ironico, da questo punto di vista, pensare che proprio il nostro mondo, che ha a lungo lottato per l’affermazione dei diritti umani, venga, almeno in parte, additato quale responsabile di oppressione verso i popoli del cosiddetto sud del mondo. A riprova del fatto che i diritti umani sono il frutto del pensiero occidentale basti un’ulteriore osservazione. Il rappresentante iraniano all’O.N.U. durante la dichiarazione di voto sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo aveva sostenuto che nel documento si rappresentava una interpretazione laica della tradizione giudaico-cristiana che gli Stati islamici non avrebbero potuto accettare perché in contrasto con le norme del Corano. Al punto di adottare una propria Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo, anzi due. La prima, Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo, proclamata all’UNESCO di Parigi il 19 settembre 1981, arriva oltre 30 anni dopo quella dell’O.N.U., la seconda del 1990, al Cairo, 19a Conferenza Islamica dei Ministri degli Esteri (dal 31 luglio al 5 agosto), é definita Dichiarazione del Cairo dei Diritti Umani dell’Islam.
Da un lato, il filosofo e storico francese contemporaneo Marcel Gauchet parla di sacralizzazione dei diritti umani. D’altro canto, la scienza politica bolla la proliferazione indiscriminata dei diritti come principale causa di crisi del Welfare State che nel ‘900 sostituisce lo Stato di diritto proponendosi l’obiettivo di una fantomatica giustizia sociale senza badare in cosa essa possa davvero consistere e senza preoccuparsi di verificare se le risorse disponibili possano permettere simile munificienza ma, soprattutto, senza avere riguardo a due principi fondamentali di comportamento: il principio di realtà che impone di osservare le cose per ciò che sono e non per come piacerebbe fossero e il principio di responsabilità che nella vita ed in politica impone di esaminare realisticamente le conseguenze delle proprie azioni, ponendosi la domanda E dopo? equivalente in economia all’interrogativo: Chi paga? Senza pensare in altri termini che:
- se lo Stato dà con il c.d. welfare qualcosa di più di quanto potrebbe dare o se in famiglia si spende più di quanto si guadagna si creano per lo Stato uno squilibrio di bilancio che porta ad una crisi finanziaria e per la famiglia un indebitamento progressivo, almeno finché si trova chi è disposto a concedere credito, che genera un onere cui figli, nipoti e pronipoti dovranno far fronte in futuro. Vale ricordare che vivere al di là dei propri mezzi implica dipendenza invece che indipendenza e che la dipendenza conduce al degrado
- se ciò che lo Stato pretende con la tassazione è più di quanto non sia strettamente necessario – se, cioè, le entrate tributarie sequestrano tutta o gran parte della nuova ricchezza che si viene creando così da disincentivarne ineluttabilmente la produzione – altrettanto irreparabilmente si compromettono le opportunità di sviluppo e di crescita di un Paese.
Si sono ricordati spesso due esempi classici: alla base del collasso dell’Impero romano nei tempi antichi e di quello sovietico nei tempi moderni, pur in carenza di attacchi dall’esterno, c’é un livello di parassitismo politico che, prosperando allegramente con la tassazione, ha superato quello della produzione di risorse facendo implodere il sistema.
Da un regime di Welfare State discende, anche se attraverso varie forme intermedie, l’idea di uno Stato etico che, a tutto pensando e a tutto provvedendo, rende superflua la libertà individuale. Lo Stato moderno si forma in Occidente nel ‘500, originale rispetto alla polis greca ed alla res publica romana, ha regole diverse da quelle proprie del sistema feudale, progredisce nell’800 trasformando la Monarchia assoluta in Monarchia costituzionale e poi creando lo Stato di diritto. Dopo un ininterrotto tragitto per assicurare la libertà all’uomo, con il Welfare State senza limiti e lo Stato etico imperante ci si ritroverebbe al punto di partenza e si contraddirrebbero i presupposti di fondo della libertà dato che lo Stato etico ha non solo il controllo sociale ma anche la direzione sociale. Lo Stato etico, in altri termini, dirige i cittadini verso certi obbiettivi, si arroga il diritto di dire all’uomo come vivere, cosa pensare, che desiderare, addirittura come mangiare pretendendo che i cittadini siano al suo servizio e non sia viceversa. Lo Stato smette così di essere il baluardo a difesa dei diritti individuali del cittadino come insegna la dichiarazione universale dei diritti umani.
Giuseppe Mazzini é l’autore dei Doveri dell’Uomo, scritto ormai più di un secolo e mezzo fa, una teoria della filosofia del diritto con un’impronta di base giusnaturalista, un tratto classista (il libro si rivolgeva alle masse operaie) ma anche nazionalista (nel senso mazziniano del termine) e, comunque, profondamente cristiano che propone un pregnante insegnamento vero quando, a proposito di diritti, impone l’opportunità di ragionare sul loro speculare logico, i doveri, esponendo una filosofia di vita che indica nei doveri il mezzo per godere dei diritti. I diritti, secondo Giuseppe Mazzini, non si reggono da soli. Colla teoria della felicità, del benessere dato per oggetto primo alla vita – suggerisce – noi formeremo uomini egoisti, adoratori della materia, che porteranno le vecchie passioni nell’ordine nuovo e lo corromperanno pochi mesi dopo. L’emancipazione dei popoli passa così da una previa ma indispensabile assunzione di responsabilità. Il bene nel mondo si realizza attraverso il sacrificio e l’abnegazione, con l’educazione e con la moralizzazione dei costumi a livello individuale ed il perfezionamento morale di se stesso attraverso gli altri e per gli altri. Per Giuseppe Mazzini a formare il nucleo centrale della vita stanno la Famiglia, la Nazione, l’Umanità. Anche Friedrich Hegel distingueva tre sfere di impegno. Per lui erano la famiglia, la società civile e lo Stato. Fatte salve le ovvie differenze ideologiche che differenziano i due personaggi, le difformità di pensiero fra loro non sembrano poi così insormontabili. Sono valori importanti ma valori, però, al giorno d’oggi in crisi: la Famiglia è aggredita da rivendicazioni e prospettive progressiste che tendono a stravolgerne persino i più genuini ed umani connotati, la Nazione si diluisce in un contesto sociale allargato che, libero da vincoli spaziali e temporali, finisce con l’essere attratto od assorbito da mere esigenze organizzative e tende a schiacciarsi sul presente, togliendo peso sia alla tradizione, sia al futuro, l’Umanità sembrerebbe allontanarsi vieppiù da quella rivoluzione (non solo pacifica, ma anche ascetica, in cui Dio e la sua Legge sono motori potenti e invisibili) che Giuseppe Mazzini si immaginava.
© Carlo Callioni 2012